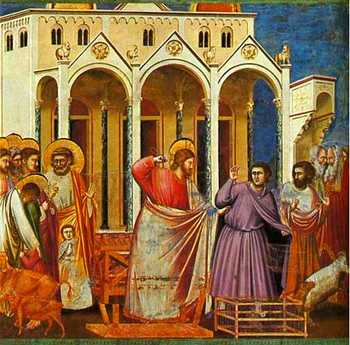Attualizzazioni
 |  | 16 / 49 |
 |  |
(26-02-2012)
La vittoria di Cristo contro il maligno
e l’annuncio del Regno di Dio
(12) Subito lo Spirito lo sospinge nel deserto
(13) e stava nel deserto quaranta giorni, tentato da satana;
stava con le fiere e gli angeli lo servivano.
(14) Dopo che Giovanni fu consegnato, Gesù andò nella Galilea,
proclamando l’evangelo di Dio
(15) e dicendo:
“È compiuto il tempo e il regno di Dio si è fatto vicino;
convertitevi e credete nell’evangelo”.
La narrazione delle
tentazioni (Mc 1,12-13) non si ferma sui particolari, ma vuole dimostrare la
fermezza di Gesù, la sua disponibilità totale a seguire un messianismo conforme
alla volontà di Dio, di senso totalmente opposto alle prospettive umane. Il
deserto nella tradizione giudaica indica il luogo della prova e della sofferenza
(cf. Dt 8,2s). Esso ricorda i quaranta anni trascorsi da Israele
nell’isolamento: un’epoca di stenti, di ostacoli e di purificazione. Proprio in
questo ambiente, così ricco di risonanze bibliche, il diavolo mette alla prova
Gesù, una prova che sembra abbracciare tutto il periodo dei quaranta giorni.
Satana non riesce a piegare la volontà di Cristo, il Figlio prediletto e l’uomo
giusto, il quale resta decisamente sottomesso al disegno del Padre e in piena
comunione con lui. Marco non intende tanto descrivere le tentazioni, la qualità
o il numero, quanto sottolineare lo stato di fiduciosa sopportazione da parte di
Gesù e la sua opposizione al maligno. Egli ne esce vittorioso.
Alla fine vive in comunione con animali selvaggi, mentre gli angeli lo servono.
Ciò probabilmente anticipa l’evento escatologico della pace universale, secondo
quanto annunciato anche da Isaia (cf. 11,6; 65,25). Con Cristo inizia la
restaurazione dell’armonia nell’universo e tutto viene rinnovato; ormai è giunto
il tempo ultimo e definitivo della salvezza. Il servizio degli angeli indica
ugualmente la condizione di amicizia con Dio e con i suoi ministri, quale segno
concreto della realizzazione salvifica.
Con gli altri due versetti (Mc 14-15) il Vangelo affronta l’inizio della
missione di Gesù in Galilea. Prima di addentrarsi nei particolari della sua vita
pubblica, nelle determinate e circoscritte azioni del suo ministero, nei suoi
interventi salvifici e liberatori, Marco presenta un sommario alquanto succinto.
Anzitutto si dichiara che Gesù inizia la missione dopo che Giovanni fu
arrestato. La prigionia pone fine all’attività del Battista. La sua funzione è
terminata, si è conclusa, dal momento che ha introdotto la persona attesa. Il
più forte, colui al quale non è degno di sciogliere i legacci dei sandali, colui
che battezzerà nello Spirito Santo è ormai giunto. Il precursore può tirarsi da
parte.
Gesù si mostra come un banditore, un araldo, un annunciatore della buona
notizia, per diffondere la quale percorre in lungo e in largo la Galilea.
Nell’antichità erano molti i banditori che erano mandati dai sovrani e passavano
di luogo in luogo a notificare ordini, avvisi, eventi significativi. Anche
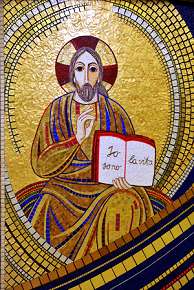 Gesù ha una
notizia da dire, che non proviene da un’autorità umana, ma da Dio, in quanto
proclama la venuta del suo regno. Egli quindi si presenta come l’inviato da Dio,
in modo che alza la voce per far risuonare il messaggio che Dio vuol comunicare
o, meglio, quello che sta per fare e quello che desidera che gli uomini
facciano. Gesù dichiara che “è compiuto il tempo”. Un’affermazione densa di
portata salvifica e insieme decisamente vincolante. Non c’è da indugiare o da
tentennare: il tempo è giunto al suo traguardo, oltre o fuori del quale non
esiste altra eventualità.
Gesù ha una
notizia da dire, che non proviene da un’autorità umana, ma da Dio, in quanto
proclama la venuta del suo regno. Egli quindi si presenta come l’inviato da Dio,
in modo che alza la voce per far risuonare il messaggio che Dio vuol comunicare
o, meglio, quello che sta per fare e quello che desidera che gli uomini
facciano. Gesù dichiara che “è compiuto il tempo”. Un’affermazione densa di
portata salvifica e insieme decisamente vincolante. Non c’è da indugiare o da
tentennare: il tempo è giunto al suo traguardo, oltre o fuori del quale non
esiste altra eventualità.
Se da una parte il messaggio procura gioia, dall’altra offre un ammonimento a
non lasciare sfuggire questo tempo, a riconoscerlo nel suo significato vitale e
ad accoglierlo nel modo conveniente, altrimenti si cambia in giudizio e in
condanna definitiva. Per questo esso si fa insieme annuncio e chiamata. Dopo
aver affermato con l’indicativo presente che il tempo è compiuto e che il regno
di Dio è vicino, Gesù si rivolge agli ascoltatori in forma imperativa:
“Convertitevi e credete nell’evangelo”. Gesù chiede la conversione, la quale
comporta un cambiamento radicale di mentalità, in riferimento ai desideri, ai
progetti, ai modi di pensare e di sentire puramente umani e terreni. Occorre
tagliare corto con il precedente modo di vedere il mondo e ri-orientare tutta la
propria esistenza in direzione del regno che viene ed è in atto. È questione di
un vero capovolgimento della propria direttiva esistenziale.
Gesù ne fa un comandamento irremovibile (“convertitevi”), per segnalare che non
è in ballo una decisione facoltativa, ma occorre prendere sul serio la
risoluzione piena e totalizzante del ritorno a Dio, che si fa vicino con il suo
dominio salvifico. Alla fine Gesù aggiunge ancora un invito: “Credete
nell’evangelo”, richiamando gli uomini alla disponibilità ad accogliere ciò che
lui dice, a fidarsi di quanto Dio sta per fare per mezzo di lui. Credere
significa riconoscere come vere e valide le realtà da lui annunciate, per
costruire su di esse la nuova vita. Si tratta di fidarsi di Lui, come unica
Parola di vita, di salvezza e di amore.
(04-03-2012)
L'esperienza
divina sul monte (Mc 9,2-9)
2In quel tempoi Gesù prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni
e li conduce su un alto monte, in disparte, loro soli.
Fu trasfigurato davanti a loro,
3e le sue vesti divennero splendenti, bianche assai,
che nessun lavandaio sulla terra può renderle così bianche.
4E fu visto da loro Elia con Mosè, ed erano in colloquio con Gesù.
5Allora Pietro, rispondendo, dice a Gesù:
“Rabbi, bene è che noi siamo qui;
faremo tre tende: una per te, una per Mosè e una per Elia”.
6Non sapeva infatti cosa rispondere, poiché furono spaventati.
7Allora ci fu una nube che li adombrò e ci fu una voce dalla nube:
“Questi è il Figlio mio, l’amato; ascoltate lui”.
8E improvvisamente, guardandosi attorno,
non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro.
9Mentre essi scendevano dal monte, ordinò loro
di non raccontare a nessuno le cose che avevano visto,
se non quando il Figlio dell’uomo sarebbe risuscitato dai morti.
Il maestro conduce i tre “su un alto monte”, non tanto per il bisogno di
solitudine e di preghiera. Nell’AT la montagna è il luogo della rivelazione
divina per eccellenza, il trono su cui risiede e si manifesta Jhwh. Sul Sinai
Mosè incontra Dio e riceve le tavole della legge; anche Elia vi sale in quanto
profeta perseguitato, vi si rifugia e lassù incontra il vero Dio per ricevere
nuovi incarichi. Pertanto Gesù vuole far entrare i tre in una dimensione che li
pone in contatto con Dio e con la testimonianza che il Padre darà in favore di
Gesù dichiarandolo suo Figlio.
Giunti sul monte inizia una solenne rivelazione. Il testo afferma repentinamente
che Gesù “fu trasfigurato”. Il verbo, posto al passivo (metemorphōthē), allude
all’azione divina. Solo Dio può operare una trasformazione così sublime e
folgorante, che non ha alcun paragone di confronto. Marco lo sottolinea con
sagacia, facendo riferimento all’azione umana di un lavandaio, che tuttavia non
riesce a rendere così bianche le vesti risplendenti di Gesù. Ne deriva che egli
non è soggetto ad alcuna azione umana, ma è immerso nella sfera divina.
In effetti le sue vesti, data la loro luminosità, splendono di una bianchezza
ultraterrena, tipica degli esseri celesti che appartengono al mondo divino. Gesù
così contrae un aspetto sovraterrestre.
Il testo evangelico prosegue: “E fu visto da loro Elia con Mosè, ed erano in
colloquio con Gesù” (v. 4). Mosè ed Elia rappresentano le due figure dell’AT
legate al monte Oreb o Sinai. Mosè ricorda la conclusione del patto tra Dio e
Israele e rimanda conseguentemente al dono della legge; Elia indica la lotta dei
profeti perché il popolo d’Israele rimanesse fedele all’alleanza. La presenza di
Mosè e di Elia vuole significare che su questa montagna, come nuovo Sinai, in
virtù di Gesù si sta compiendo la salvezza definitiva. La legge e i profeti, da
essi rappresentati, confermano l’attuazione in Cristo del piano di Dio; in lui
tutta la storia e le istituzioni di Israele trovano il loro compimento; in lui
si realizza il nuovo esodo, la nuova definitiva pasqua.
Alla luminosa rivelazione segue immediata la reazione di Pietro e dei suoi
compagni. Non viene sottaciuto lo sgomento: “Furono spaventati”. Il turbamento
afferra tutti tre i discepoli, sebbene solo Pietro azzardi a parlare. Egli dice
inoltre: “Bene è che noi siamo qui” (v. 5b). Pietro esterna la propria felicità
(kalos nel significato di “bello”), provocata dalla singolare situazione che sta
vivendo. Insieme propone a Gesù di erigere tre capanne con il desiderio di
rendere permanente quell’esperienza. A tale scopo vorrebbe sollecitare quei
personaggi a restare lì, trasfigurati e meravigliosi, esposti all’ammirazione
sua e dei suoi compagni, per essere avvolti per sempre in quell’evento d’intensa
beatitudine. In questa ottica le parole di Pietro sembrano contrapporsi al senso
di quanto Gesù aveva detto sul cammino verso la croce per raggiungere la
risurrezione. Invece Pietro ripropone l’idea di rimanere fermi, perché “è bello”
quanto i discepoli stanno ammirando.
Mentre prende il sopravvento l’umana incomprensione di Pietro, interviene
prontamente Dio per proclamare l’identità di Gesù. Sono avvolti dall’ombra di
una nube da cui proviene una voce. Nella tradizione biblica la nube accompagna
le manifestazioni divine. Sul monte Sinai costituiva un segno della presenza di
Dio, nascosta e potente. Nel percorso delle zone desertiche essa ricopriva la
tenda del convegno, mentre la gloria di Dio riempiva la dimora.
Nel nostro testo la nube diventa il contesto privilegiato e il modo attraverso
il quale Dio non solo si rende presente, ma si fa vivo e rivolge la parola ai
tre discepoli, con una dichiarazione esplicita e definitiva: “Questi è il Figlio
mio, l’amato” (v. 7b); e prosegue con un ordine perentorio e autorevole:
“Ascoltate lui”.
I discepoli apprendono direttamente dall’Onnipotente l’identità propria di Gesù.
È Dio che lo dichiara e lo mostra quale suo Figlio amato. Non esiste una
proclamazione e una rivelazione più luminosa e dichiarativa di questa. Anzitutto
perché proviene dalla fonte suprema della verità e dell’amore, cioè dall’essere
stesso divino. In secondo luogo essa fa luce totale sulla persona di Cristo, in
modo che non si possa più falsificare o confondere o non recepire nella sua
interezza e profondità. Veramente la teofania della trasfigurazione giunge
inequivocabilmente negli abissi insondabili e radiosi del mistero di Cristo.
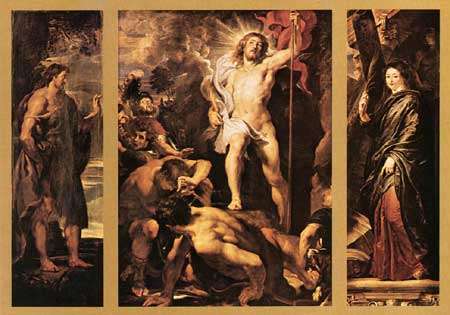
Tra Cristo e Dio si palesa una relazione di origine, quale Figlio generato dal
Padre, e insieme si dimostra la loro parità di essere, in quanto Gesù non è
posto nel rango di servo, come lo sono Mosè ed Elia, ma è innalzato alla dignità
di Figlio. La tenera e vigorosa designazione di essere “l’amato” evidenzia la
unicità di predilezione, con cui il Padre lo considera e giustamente lo enuncia.
Da questo augusto riconoscimento procede l’invito ad “ascoltare lui”, con
l’imperativo presente, per indicare che l’ascolto va fatto in modo continuativo
e incondizionatamente. Proprio in ragione che Gesù è il Figlio di Dio, i
discepoli sono chiamati ad obbedire alle sue parole. Li obbliga all’ascolto non
tanto il contenuto o la qualità di quanto egli dice, ma l’identità della sua
persona. È il Figlio che parla, non uno dei numerosi maestri. Più specificamente
l’autorevole dichiarazione mostra che Gesù va accettato soprattutto nella sua
missione che prossimamente si consumerà a Gerusalemme con la morte in croce e la
risurrezione. Anche se appare scandalosa e sconveniente, essa costituisce
l’espressione autentica della suprema volontà divina: corrisponde al disegno
salvifico del Padre. I discepoli debbono credere e riporre in Gesù tutta la loro
fiducia e speranza; egli è il Figlio diletto.
La teofania si conclude con l’indicazione che i tre apostoli non vedono più
nessuno se non Gesù solo con loro. Le due figure anticotestamentarie sono
scomparse; i discepoli non le vedono più, perché non ne sentono il bisogno, dato
che hanno con loro il Figlio diletto, subentrato ai servi. Non sentono più la
voce del Padre, ma devono ascoltare quella del Figlio, in cui il Padre vuole
rivelare la sua verità totale. Ciò che conta è che Gesù sia ancora con loro e
loro con lui, per sottolineare che quel personaggio eccelso, il Figlio amato del
Padre, s’identifica con l’uomo Gesù, il quale, dopo l’episodio folgorante della
trasfigurazione, si trova solo con i tre discepoli.
Don Renzo Lavatori
(11-03-2012)
Il nuovo
tempio sostituisce l'antico
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel
tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete.
Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le
pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i
banchi, e ai venditori di colombe disse: “Portate via di qui queste cose e non
fate della casa del Padre mio un mercato!”. I suoi discepoli si ricordarono che
sta scritto: “Lo zelo per la tua casa mi divorerà”. Allora i Giudei presero la
parola e gli dissero: “Quale segno ci mostri per fare queste cose?”. Rispose
loro Gesù: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. Gli
dissero allora i Giudei: “questo tempio è stato costruito in quarantasei anni e
tu in tre giorni lo farai risorgere?”. Ma egli parlava del tempio del suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva
detto questo e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre era
a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli
compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché
conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’ uomo.
Egli infatti, conosceva quello che c’è nell’ uomo. ( Gv 2,13-25).
Nel brano evangelico possiamo costatare tre gesti significativi che compie Gesù:
Il primo è la cacciata dei mercanti dal tempio (gesto autorevole); il secondo
corrisponde alle parole che Gesù dice in vista della sua Pasqua di morte e di
resurrezione (gesto messianico); Infine il terzo indica la facoltà introspettiva
di Gesù (gesto profetico).
Quanto al sovvertimento operato nel’ambiente del tempio dove si vendeva e
comprava ogni genere di bestiame con lo scopo dei sacrifici cultuali, esso sta a
significare che Gesù possiede una autorità superiore al tempio stesso, vale a
dire si rivela quale uomo religioso inviato da Dio e rivestito di una potenza
divina. Di fatto egli spiega il gesto compiuto dichiarando che quel luogo non
deve essere profanato in quanto costituisce la casa del Padre suo. Con ciò
afferma esplicitamente che Dio è suo Padre, mostrando un rapporto di profonda
comunione con lui quale suo figlio e messaggero. Oltre all’ aspetto rivelatore
della sua identità, Gesù fa capire che quel luogo sacro, espressione della vita
spirituale e liturgica del popolo, va purificato, rinnovato e ricostruito in una
dimensione nuova in forza propriamente della sua persona e dell’opera che è
venuto a realizzare. Si apre una visione nuova in torno all’ antico tempio di
Gerusalemme e a tutta la vita religiosa di quel popolo, come si trattasse di un
cambiamento e di un passaggio di altissimo valore culturale e religioso. Da una
parte Gesù segna la fine di una economia religiosa fondata sul ritualismo legato
ai dettami della Legge osservati esternamente ma che non hanno il potere di
muovere l’adesione del cuore; dall’altra parte egli inaugura una epoca nuova in
cui sorgeranno i veri adoratori di Dio in Spirito e verità. Di questi egli è
l’iniziatore e il realizzatore in conformità al progetto salvifico del Padre
suo.
 Da qui sorge la
forte reazione dei Giudei che lo rimproverano ed esigono di mostrare un segno
visibile che confermi l’autorevolezza del suo comportamento. A questo punto Gesù
offre una luminosa rivelazione della sua opera redentrice che costituisce
l’avvio di un nuovo culto e di un nuovo tempio. Di proclama profeticamente:
“distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. Parole umanamente
assurde e inaudite, che suscitano subito la opposizione dei Giudei e la loro
condanna. Ma Gesù, commenta l’evangelista: intendeva parlare del tempio del suo
corpo. Ecco la novità sconvolgente: Il nuovo luogo di culto non è più il grande
solenne edificio di Gerusalemme, ma Cristo stesso nel suo corpo immolato e
risorto, non solo nel senso fisico ma il corpo va inteso anche nell’ aspetto
sociale di coloro che con il battessimo fanno parte della Chiesa corpo mistico
di Cristo e sono uniti a lui come un solo organismo spirituale. Si fa luce sull’
evento pasquale di Gesù, dove egli esercita il vero culto di oblazione al Padre
attraverso l’offerta sacrificale del suo corpo crocifisso. Egli attua tale
offerta unicamente per amore, trasformando la morte in un momento di grazia e di
salvezza. Lì sulla croce egli diventa sacerdote vittima e tempio del nuovo culto
reso a Dio suo Padre e atto di redenzione e di salvezza per gli uomini.
Da qui sorge la
forte reazione dei Giudei che lo rimproverano ed esigono di mostrare un segno
visibile che confermi l’autorevolezza del suo comportamento. A questo punto Gesù
offre una luminosa rivelazione della sua opera redentrice che costituisce
l’avvio di un nuovo culto e di un nuovo tempio. Di proclama profeticamente:
“distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”. Parole umanamente
assurde e inaudite, che suscitano subito la opposizione dei Giudei e la loro
condanna. Ma Gesù, commenta l’evangelista: intendeva parlare del tempio del suo
corpo. Ecco la novità sconvolgente: Il nuovo luogo di culto non è più il grande
solenne edificio di Gerusalemme, ma Cristo stesso nel suo corpo immolato e
risorto, non solo nel senso fisico ma il corpo va inteso anche nell’ aspetto
sociale di coloro che con il battessimo fanno parte della Chiesa corpo mistico
di Cristo e sono uniti a lui come un solo organismo spirituale. Si fa luce sull’
evento pasquale di Gesù, dove egli esercita il vero culto di oblazione al Padre
attraverso l’offerta sacrificale del suo corpo crocifisso. Egli attua tale
offerta unicamente per amore, trasformando la morte in un momento di grazia e di
salvezza. Lì sulla croce egli diventa sacerdote vittima e tempio del nuovo culto
reso a Dio suo Padre e atto di redenzione e di salvezza per gli uomini.
Alla fine il brano evangelico si conclude sottolineando la capacità
introspettiva che fa vedere a Gesù i sentimenti del cuore umano in modo da non
aver bisogno di altre testimonianze. Egli sa riconoscere chi è mosso da vera
fede e sincero amore, per cui nessuno può nascondersi davanti a lui. Tale fatto
diventa per noi cristiani una sollecitazione a saper purificare il nostro animo
da sentimenti e da azioni che non corrispondono al culto in spirito e verità a
Dio Padre. Così si richiede per mezzo del Figlio suo Gesù con la grazia dello
Spirito Santo una totale conversione. La quaresima ci sospinge a muoverci su
questa strada per poter vivere una totale risurrezione nella luce e nell’amore
di Gesù, in modo da far morire ogni peccato e cattiveria, ogni falsità ed
egoismo che covano dentro il nostro cuore e che Gesù vuole estirpare
radicalmente per fare della nostra persona e della nostra vita un atto sincero
di adorazione e di sottomissione al Signore.
Don Renzo Lavatori
(18-03-2012)
Amore e Giustizia di Dio Padre nel figlio crocifisso
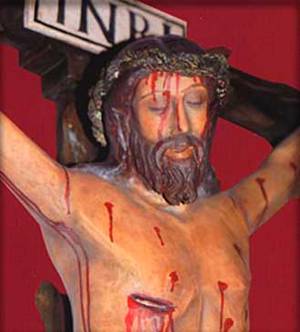 In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: “Come Mosè innalzò il serpente nel
deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio del uomo, perché chiunque
crede in noi abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare
il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la
vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il
mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è
condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel
nome dell’ unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel
mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro
opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene
alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità
viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte
in Dio. (Gv 3,14-21)
In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: “Come Mosè innalzò il serpente nel
deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio del uomo, perché chiunque
crede in noi abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare
il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la
vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il
mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è
condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel
nome dell’ unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel
mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro
opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene
alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità
viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte
in Dio. (Gv 3,14-21)
In questo brano del vangelo di Giovanni possiamo fermare l’attenzione su due
aspetti essenziali della vita cristiana: l’uno, più gioioso e luminoso, riguarda
l’infinito amore di Dio Padre per noi creature umane; l’altro, più forte e
rigoroso, concerne il giudizio divino per coloro che non hanno accolto il suo
amore e non hanno creduto nel Figlio suo. L’amore e il giudizio costituiscono
due facce della medesima medaglia e non possono separarsi ma si sostengono l’una
con l’altra. Infatti l’amore per sua natura esige che sia accolto nella
reciproca corrispondenza tra l’amante e l’amato, altrimenti l’amore resta
incompiuto e l’amato rimane chiuso nella propria incomunicabilità che forma la
sua prigionia e condanna.
1. L’amore di Dio viene espresso da tre eventi di immenso valore che ne rivelano
la grandezza e la bellezza. Il primo descrive in anticipo quella che sarà la
missione redentrice del Figlio di Dio incarnato, che sarà innalzato sulla croce,
verrà cioè crocifisso quale atto di oblazione generosa e gratuita della propria
vita per la salvezza degli uomini schiavi del peccato e della morte. Un’opera di
infinita benevolenza, che era stata preconizzata dall’episodio del serpente di
bronzo innalzato su di un’asta, che salvava il popolo ebraico dai morsi dei
serpenti per la loro ribellione lungo il percorso dell’esodo. Ma tale gesto
doveva essere accompagnato dalla consapevolezza e compunzione dei propri
peccati. Similmente avviene con la morte in croce di Cristo, che ha offerto la
vita per il nostro riscatto in conformità al progetto del Padre, il quale ha
tanto amato il mondo da sacrificare il Figlio unigenito. Il secondo aspetto
sottolinea che tale gesto richiede la corrispondenza degli uomini, i quali sono
invitati a credere all’amore di Dio nei loro confronti e affidarsi alla sua
misericordia, riconoscendo la propria miseria e il bisogno della divina grazia
per essere salvati dal male e dalla morte. Si tratta di una stretta
collaborazione tra l’offerta amorevole di Dio nel Figlio crocifisso e l’adesione
fiduciosa della creatura umana. In terzo luogo si dice che per questa ragione
Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo ma per salvarlo
per mezzo di lui. Si vede chiaramente che viene affermato il primato dell’amore
pieno e generoso di Dio verso l’umanità. Ciò costituisce il dato di fondo che va
capito, accolto e vissuto.
 2. Se non si attua tale cooperazione tra Dio e l’uomo, succede inevitabilmente
il giudizio di Dio, nel senso che il suo amore infinitamente grande viene
respinto e rifiutato dagli uomini chiusi nel proprio egoismo e disprezzanti del
dono divino. Per essi non resta altro che la condanna, perché non hanno creduto
nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. la condanna sta precisamente nel rimanere
schiavi del male e della morte, prigionieri del peccato, della cattiveria, delle
molteplici e svariate sofferenze fisiche, psichiche e spirituali. Sono dei
poveri disgraziati, perché non hanno aderito alla offerta benefica del
Salvatore, ma hanno preferito la propria miseria umana. Ne segue che il giudizio
appare molto chiaro e preciso: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno
amato più le tenebre che la luce. Terrificante e amara considerazione! Contro di
essi non si può fare alcun appello o alcuna giustificazione, ma semplicemente
riconoscere l’assurdità e la mostruosità di coloro che antepongono l’oscurità
del male alla luminosità del bene. D’altronde, conclude il vangelo, chi fa il
male odia la luce e non viene alla luce, perché le loro opere non siano svelate
e riprovate. Occorre prendere atto seriamente di queste parole austere ma vere.
2. Se non si attua tale cooperazione tra Dio e l’uomo, succede inevitabilmente
il giudizio di Dio, nel senso che il suo amore infinitamente grande viene
respinto e rifiutato dagli uomini chiusi nel proprio egoismo e disprezzanti del
dono divino. Per essi non resta altro che la condanna, perché non hanno creduto
nel nome dell’unigenito Figlio di Dio. la condanna sta precisamente nel rimanere
schiavi del male e della morte, prigionieri del peccato, della cattiveria, delle
molteplici e svariate sofferenze fisiche, psichiche e spirituali. Sono dei
poveri disgraziati, perché non hanno aderito alla offerta benefica del
Salvatore, ma hanno preferito la propria miseria umana. Ne segue che il giudizio
appare molto chiaro e preciso: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno
amato più le tenebre che la luce. Terrificante e amara considerazione! Contro di
essi non si può fare alcun appello o alcuna giustificazione, ma semplicemente
riconoscere l’assurdità e la mostruosità di coloro che antepongono l’oscurità
del male alla luminosità del bene. D’altronde, conclude il vangelo, chi fa il
male odia la luce e non viene alla luce, perché le loro opere non siano svelate
e riprovate. Occorre prendere atto seriamente di queste parole austere ma vere.
A noi, cristiani di questo tempo turbato e disorientato, dove le tenebre della
malvagità sembrano offuscare la luce del bene e del vero, si richiede una chiara
presa di coscienza e un decisivo orientamento interiore: amare e cercare la luce
che proviene da Cristo salvatore, dalle sue parole di vita e dal suo amore
donato in pienezza sulla croce. Là troviamo la fonte della rinascita spirituale,
del bene, della verità e della speranza. Non si può rimanere nella incertezza o,
peggio ancora, nella oscurità della corruzione e disonestà, attanagliati
dall’angoscia e dalla sofferenza. Alziamo la testa, il cuore, tutta la nostra
persona, fissando lo sguardo verso Cristo crocifisso e dare a lui con la
totalità del nostro essere l’adesione sincera e concreta. Allora potrà nascere
una umanità nuova e serena, redenta e illuminata dall’amore infinito del Padre
che ci ha donato il suo Figlio per dirci concretamente la profondità, la
grandezza, la sublimità del suo amore misericordioso. Se questo non lo facciamo,
purtroppo restiamo soggiogati dalla cattiveria, da ogni sorta di male e dalla
morte.
Don Renzo Lavatori
(25-03-2012)
Vedere Gesu' e riconoscerlo nella croce
 In quel tempo, tra
quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni
Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli
domandarono: “Signore, vogliamo vedere Gesù”. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e
poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: “E’ venuta
l’ora che il Figlio del uomo sia glorificato. In verità io vi dico: se il chicco
di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce
molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in
questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi
segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre
lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvame da
quest’ora? ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il
tuo nome”. Venne allora una voce dal cielo: “L’ho glorificato e lo glorificherò
ancora!”. La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un
tuono. Altri dicevano: “Un angelo gli ha parlato”. Disse Gesù: “Questa voce non
è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe
di questo mondo sarà gettato fuori, ed io quando sarò innalzato da terra,
attirerò tutti a me.” Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.
(Gv. 12, 20-33)
In quel tempo, tra
quelli che erano saliti per il culto durante la festa c’erano anche alcuni
Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli
domandarono: “Signore, vogliamo vedere Gesù”. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e
poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: “E’ venuta
l’ora che il Figlio del uomo sia glorificato. In verità io vi dico: se il chicco
di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce
molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in
questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi
segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre
lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvame da
quest’ora? ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il
tuo nome”. Venne allora una voce dal cielo: “L’ho glorificato e lo glorificherò
ancora!”. La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un
tuono. Altri dicevano: “Un angelo gli ha parlato”. Disse Gesù: “Questa voce non
è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe
di questo mondo sarà gettato fuori, ed io quando sarò innalzato da terra,
attirerò tutti a me.” Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.
(Gv. 12, 20-33)
Il brano evangelico mette sotto i nostri occhi il mistero pasquale e ci fa
intendere che possiamo vedere Gesù solo se riconosciamo il senso profondo della
sua morte. Lì, sulla croce, ci è consentito di contemplare il vero volto di
Cristo e comprendere il disegno salvifico voluto dal Padre, quello di dover
passare attraverso l’annientamento della propria vita per giungere alla piena
glorificazione.
Infatti, alcuni Greci, cioè gente pagana, chiedono di “voler vedere Gesù”, non
solo a livello fisico, ma più profondamente poterlo individuare nella sua realtà
profetica e taumaturgica. Alla loro richiesta fatta attraverso gli apostoli
Filippo e Andrea, Gesù dà una risposta sorprendente, al di fuori di ogni logica
umana. Dice che egli sarà glorificato ma in maniera insolita e dolorosa, come il
chicco di grano che, caduto in terra, marcisce per poi produrre frutto
abbondante. Ma non basta. Per vedere Gesù non è sufficiente assistere al suo
martirio, è necessario inoltre compartecipare al suo destino, condividere il suo
annientamento, morire con lui. Allora, si potranno capire veramente e totalmente
la sua figura e la sua missione. Non vi è altra strada. Lo afferma chiaramente:
“Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo la
conserverà per la vita eterna”. Parole forti e inequivocabili, ma che esprimono
bene la via da percorrere per i suoi seguaci. In effetti, occorre guardare lui e
seguire il suo camino che conduce inesorabilmente al proprio annientamento per
ritrovarsi trasfigurati con lui nella gloria della vita eterna. Questa visione
costituisce il nucleo del mistero di Cristo e della sua opera redentrice. Solo
servendo Gesù e restando al suo seguito, il discepolo sarà onorato dal Padre.
 In un secondo
momento, Gesù mostra la sua angoscia mortale: “Adesso l’anima mia è turbata.”.
Tuttavia non si abbandona alla sfiducia, non si arrende davanti al sacrificio
totale di se stesso, ma si dona totalmente al volere del Padre, perché in tal
modo il Padre viene glorificato e anche il Figlio sarà glorificato. Arriva la
conferma di questa realtà da una voce dal cielo, che alcuni pensano sia un tuono
ed altri un angelo. Ma Gesù chiarifica che questa voce è una rivelazione
dell’opera salvifica di Cristo, perché con la sua morte si attua il giudizio
contro la mentalità mondana e si avvera la condanna del principe di questo
mondo, satana. Ciò significa che con la morte in croce si compie la salvezza
degli uomini che si aprono all’amore di Cristo crocifisso. Proprio sulla croce
quando sarà innalzato da terra, Gesù diventerà il punto di attrazione per tutti
gli uomini. Si nota uno strano paradosso: Il fatto della morte in croce, che
umanamente sembra il più grande fallimento e una totale distruzione, diventa
invece il momento di una vittoria piena sul male, sul peccato e sulla morte per
essere un segno di immenso valore per coloro che lo guarderanno con fede e con
intima compunzione. In questo modo Gesù rivela effettivamente la sua identità e
la sua opera di redenzione per gli uomini.
In un secondo
momento, Gesù mostra la sua angoscia mortale: “Adesso l’anima mia è turbata.”.
Tuttavia non si abbandona alla sfiducia, non si arrende davanti al sacrificio
totale di se stesso, ma si dona totalmente al volere del Padre, perché in tal
modo il Padre viene glorificato e anche il Figlio sarà glorificato. Arriva la
conferma di questa realtà da una voce dal cielo, che alcuni pensano sia un tuono
ed altri un angelo. Ma Gesù chiarifica che questa voce è una rivelazione
dell’opera salvifica di Cristo, perché con la sua morte si attua il giudizio
contro la mentalità mondana e si avvera la condanna del principe di questo
mondo, satana. Ciò significa che con la morte in croce si compie la salvezza
degli uomini che si aprono all’amore di Cristo crocifisso. Proprio sulla croce
quando sarà innalzato da terra, Gesù diventerà il punto di attrazione per tutti
gli uomini. Si nota uno strano paradosso: Il fatto della morte in croce, che
umanamente sembra il più grande fallimento e una totale distruzione, diventa
invece il momento di una vittoria piena sul male, sul peccato e sulla morte per
essere un segno di immenso valore per coloro che lo guarderanno con fede e con
intima compunzione. In questo modo Gesù rivela effettivamente la sua identità e
la sua opera di redenzione per gli uomini.
La conclusione appare molto chiara e abbraccia due aspetti fondamentali. L’uno
riguarda la visione vera e profonda della morte in croce di Gesù quale
rivelazione del progetto salvifico del Padre, che sa trasformare la morte in
vita, l’annullamento in glorificazione; L’altro aspetto invita ciascuno di noi a
seguire il Maestro sulla medesima traiettoria per conseguire la sua stessa vita
e gloria eterne. Il vedere dunque si accompagna al seguire per una vita
autenticamente cristiana. Questo è il mistero che la Pasqua ci indica e ci
comunica, verso il quale ci stiamo preparando nel cammino quaresimale in modo da
essere pronti ad accogliere tutto l’amore e il perdono di Gesù innalzato sulla
Croce. Solo in questo modo potremo poi ottenere una vita nuova e luminosa con la
resurrezione.
Don Renzo Lavatori
(01-04-2012)
Il Racconto della Passione
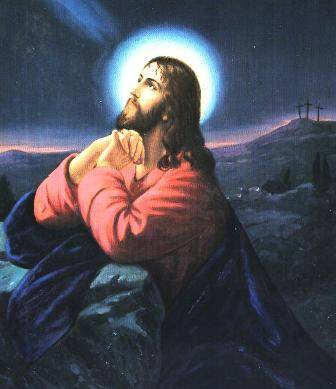 Giungono intanto in
un podere di nome Getsemani;
Giungono intanto in
un podere di nome Getsemani;
ed egli dice ai suoi discepoli: “Sedete qui, mentre io prego”.
Quindi prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni,
e cominciò ad aver terrore e angoscia.
E dice loro: “L’anima mia è triste fino a morte.
Rimanete qui e vegliate”.
E, andando avanti un po’,
si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile,
passasse da lui quell’ora.
E diceva: “Abbà, Padre. Tutte le cose (sono) possibili a te.
Togli questo calice da me; ma non ciò che voglio io, ma tu”.
E viene e li trova addormentati.
E dice a Pietro: “Simone, dormi?
Non hai avuto forza di vegliare una sola ora?
Vegliate e pregate, affinché non entriate in tentazione.
Lo spirito è pronto, ma la carne è debole”.
E di nuovo, essendosi allontanato,
pregò (dicendo) la stessa parola.
E di nuovo, tornato, li trovò addormentati.
I loro occhi, infatti, erano appesantiti
e non sapevano che cosa rispondergli.
E viene la terza volta e dice loro:
“Dormite ormai e riposate. Basta. È giunta l’ora. Ecco,
il Figlio dell’uomo è consegnato nelle mani dei peccatori.
Alzatevi, andiamo. Ecco, chi mi consegna è vicino”.
(Mc. 14,32-42)
Dopo l’ingresso glorioso a Gerusalemme, Gesù ormai si avvicina al momento finale
della sua missione. In questa domenica si legge il racconto della passione
secondo il vangelo di Marco. La nostra attenzione si rivolge alla drammatica
prova che Gesù ha dovuto affrontare nel giardino degli olivi, per conoscere la
sofferenza del suo animo e la sua angoscia profonda insieme al suo coraggio e
alla decisione di andare incontro alla morte.
1. La tristezza e il terrore di Gesù davanti a tre apostoli
Subito viene precisato il luogo dove giunge Gesù assieme ai discepoli e da dove
verrà poi prelevato: il Getsemani. Egli manifesta loro l’intenzione chiara per
cui si è recato in quel posto. Sono le ultime ore di libertà prima che “giunga
l’ora” fatidica e sia “consegnato nelle mani dei peccatori” (v. 41b). Egli, che
conosce ogni cosa, desidera rivolgersi a Dio e immergersi nel suo volere,
affinché tutto ciò che sta per attuarsi corrisponda al compimento dei suoi
disegni. Lo dice ai suoi: “Sedete qui, mentre io prego” (v. 32b).
La sua preghiera è solitaria, a tu per tu con Dio; gli altri possono ancora
rimanere seduti; poi prende con sé soltanto Pietro, Giacomo e Giovanni; infine
si separa anche da costoro. Essi sono stati presenti poi sul monte, quando hanno
contemplato Gesù trasfigurato e hanno udito la voce di Dio che lo dichiarava suo
Figlio, in un contesto che li orientava verso la morte e la risurrezione. Colui
che ora hanno davanti agli occhi non appare l’uomo forte, famoso, sfolgorante
nella luce divina, al contrario un individuo terrorizzato e angosciato:
“Cominciò ad aver terrore e angoscia” (v. 33b). Due termini che esprimono
contemporaneamente sia la repulsione e il timore davanti a quanto lo aspetta sia
la interiore amarezza e oppressione, come fosse pesantemente schiacciato da una
forza misteriosa e irrefrenabile, di fronte alla quale lui stesso ne resta
accasciato senza possibilità di ripresa e di rivincita. Loro lo vedono lì,
abbattuto, sotto un realismo di sofferenza inaudita e di cui non possono fare a
meno di calcolarne l’enorme pesantezza. I tre devono sapere e proprio a loro
Gesù esterna la sua interiore afflizione: “L’anima mia è triste fino a morte”
(v. 34a). Ne fa vedere e sentire il tenore gravissimo; non si nasconde davanti a
loro, non ha paura di farsi cogliere nella sua massima debolezza a livello
psicologico e spirituale. Tutto essi devono conoscere di lui, entrare fino in
fondo nel suo essere vero e reale. È là, anche adesso si rivela, similmente al
monte, ma sotto la realtà pienamente umana, come là si era manifestato nello
splendore divino. È lo stesso Gesù, è il loro autentico maestro.
Poco dopo si distacca e va lontano anche da Pietro, Giacomo e Giovanni. Il suo
travaglio e il suo animo pieno di terrore possono trovare luce e forza solo in
Dio. Per questo si rivolge direttamente a Lui, cadendo a terra, preso dalla
tristezza. Il testo marciano espone succintamente il contenuto della richiesta
che sgorga dal suo cuore angosciato. Egli anela e sospira affinché quell’ora
tremenda che sta per giungere vada oltre, non lo riguardi personalmente, se
questo è possibile. Ma ci si chiede chi abbia il potere di attuare tale
eventualità. Forse spetta agli uomini che fra poco si avventano contro di lui.
In quali mani è posto il destino cui è stato sottomesso?
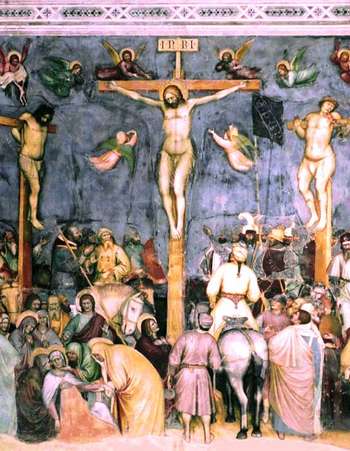 2. La forza e la
luce di Gesù nell’affidamento al Padre
2. La forza e la
luce di Gesù nell’affidamento al Padre
Il testo apre uno sguardo sull’animo di Gesù, indicando alcune espressioni che
sorgono dall’intimo e rivelano non solo lo stato interiore, ma anche la sua
costituzione fondamentale nel rapporto primario che lo unisce a Dio. Gesù,
gettatosi a terra, si rivolge a Colui che chiama ed è suo Padre. Si nota una
strana situazione: da una parte egli si immerge nella polvere come un individuo
totalmente avvinto ad essa e soppiantato dalla propria desolazione umana,
dall’altra il suo spirito si eleva fiduciosamente verso le altezze divine, dove
ritrova le coordinate della sua unione filiale con Dio Padre. Bassezza estrema
ed elevazione eccelsa: questa la manifestazione e la realtà del suo essere.
Il termine “Abbà”, solo qui usato in Marco e unico tra gli evangelisti, allude
al modo usuale dei bambini di rivolgersi al loro genitore. Un appellativo
cordiale e fiducioso. Sembra che Gesù in questo modo voglia toccare il cuore
paterno di Dio, farlo sussultare, piegarlo ai suoi desideri. Ma nello stesso
tempo sa che il Padre vuole sempre il bene del Figlio e a lui si abbandona
confidente. Si rivela la dimensione propria di Gesù nel suo essenziale rapporto
a Colui che lo ha generato, da cui attinge la luce e la forza per andare
incontro con disponibilità piena all’attuazione del progetto salvifico.
In tale simbiosi tra Padre e Figlio, resta a Gesù uno spiraglio di speranza,
proseguendo nella preghiera e sapendo di rivolgersi a Dio in quanto Dio, nella
consapevolezza della sua onnipotenza: “Tutte le cose (sono) possibili a te” (v.
36a). Si apre un varco nel suo cuore, quello che il calice di sofferenza e di
morte possa essere allontanato. Il potere assoluto di Dio può prevalere sulle
forze incombenti del male e quindi sottrarre il Figlio al grande dolore. Ma
oltre alla potenza e alla forza si fa avanti la santa volontà di Dio, la quale
rientra perfettamente nella dimensione della sua paternità.
Dio non risponde alla preghiera di Cristo con una manifestazione teofanica né
con un intervento prodigioso. È Gesù, che pur desiderando che il calice sia
tolto, tuttavia implora che sia fatta la volontà divina. In questo lancinante
momento principalmente si compie la sua vera morte. Egli muore a se stesso, alla
sua volontà, ai suoi desideri, rimettendosi completamente alla prospettiva
paterna con l’impegno di tutte le proprie forze. Là, prostrato sulla nuda terra,
avvolto dalla tristezza più acuta, tutta la sua persona si pone in assoluto
atteggiamento filiale di oblazione al volere supremo. Lui ormai ha finito il suo
compito; in questo ultimo atto di abbandono consuma la sua determinazione
d’inviato dal Padre quale Figlio fino nelle intime fibre dell’essere. In tal
modo rivela che non appartiene più a se stesso, che non ha alcun diritto da far
prevalere, che la sua libertà personale resta affrancata totalmente da sé per
avvitarsi a quella del Padre. Ora tutto è fattibile e tutto va eseguito
coerentemente: “Non ciò che voglio io, ma tu” (v. 36b).
Quando il suo animo si è rafforzato aggrappandosi al Padre, Gesù si volge verso
i suoi, come se gli avesse persi di vista, per costatare la loro situazione
spirituale, il loro modo di essere e di porsi davanti a quell’ora tremenda. Per
questo motivo egli torna subito dai tre apostoli, che aveva sollecitato a
vegliare rimanendo poco lontano da lui. Non si ripiega solo in se stesso né si
chiude dentro il suo tragico destino, ma il suo cuore si dirige anche verso di
loro. Interrompendo la preghiera per tre volte, Gesù indica la sua attenzione
nei confronti dei tre e si trova come dilaniato: interiormente si sente
sofferente e angosciato; la volontà di Dio da adempiere appare chiara; tuttavia
il pensiero e la premura sono rivolti proprio a loro. Cosa faranno senza di lui?
Aveva ordinato loro di stare svegli, li trova invece addormentati. Da qua si
staglia netto il loro distacco che li porterà a fuggire o a rinnegarlo, come
succederà a Pietro.
Per la seconda volta Gesù prega il Padre con “la stessa parola”, come per
confermare e rafforzare l’unione della sua volontà con quella paterna, in modo
da non lasciarsi sviare in alcun modo dalla totale accondiscendenza. Al
contrario il testo fa vedere come il rapporto tra Gesù e i discepoli si faccia
sempre più distante e discordante. Tutto ciò comporta la conclusione umanamente
triste, ma spiritualmente vigorosa: l’unica forza e l’unico orientamento del
Figlio rimane la fedeltà al Padre. Lì si scopre la vera forza che si effonde
nell’animo di Cristo e lo rende ormai deciso e sollecito. Le creature umane si
distaccano da lui e si disperdono. La conseguente solitudine non costituisce un
impedimento per proseguire l’attuazione della sua ora.
Il testo parla di una terza volta in cui egli dice: “Dormite ormai e riposate”
(v. 41b). Ormai non ha più importanza per loro vegliare e pregare. Il tempo
della preparazione è finito, in quanto “è giunta l’ora”. Essi possono dormire e
riposare, perché non desidera più che passi quell’ora, anzi gli va incontro con
decisione e prontezza: “Basta”. Se si è fatto vicino colui che tradisce Gesù,
affinché il Figlio dell’uomo sia consegnato “nelle mani dei peccatori”, egli
dice loro: “Alzatevi, andiamo”. Ora non è più tempo neanche di dormire, occorre
muoversi fisicamente, anche se spiritualmente addormentati. Il nemico avanza e
sta lì accanto per consumare il misfatto del tradimento: “Ecco, chi mi consegna
è vicino” (v. 42).
Don Renzo Lavatori.
(Giovedì, venerdì, sabato santi. 05,06,07/04/2012)
 I tre giorni precedenti la resurrezione di Gesù sono chiamati “santi” perché
fanno rivivere l’evento centrale della nostra redenzione; ci riconducono al
nucleo essenziale della fede cristiana: la passione, la morte e la risurrezione
di Cristo. Sono giorni che costituiscono il cuore e il fulcro dell’intero anno
liturgico come pure della vita della Chiesa e di ogni cristiano. Esso
costituisce un’unica solennità, la più importante di tutto l’anno liturgico.
I tre giorni precedenti la resurrezione di Gesù sono chiamati “santi” perché
fanno rivivere l’evento centrale della nostra redenzione; ci riconducono al
nucleo essenziale della fede cristiana: la passione, la morte e la risurrezione
di Cristo. Sono giorni che costituiscono il cuore e il fulcro dell’intero anno
liturgico come pure della vita della Chiesa e di ogni cristiano. Esso
costituisce un’unica solennità, la più importante di tutto l’anno liturgico.
1. Nel Giovedì santo, con la messa vespertina, chiamata la cena del Signore, la
Chiesa commemora la istituzione dell’eucaristia, del sacerdozio ministeriale e
anche dell’invito di Gesù al comandamento nuovo della carità. Le parole di
Cristo, pronunciate in quella occasione dentro il cenacolo, sono cariche di
mistero, in quanto manifestano con chiarezza la sua volontà di restare sempre
con noi sotto le specie del pane e del vino consacrate; egli si rende presente
con il suo corpo sacrificato e con il suo sangue versato. Ciò costituisce il
sacrificio della nuova e definitiva alleanza, offerta a tutti coloro che
vogliono nutrirsi del suo corpo e
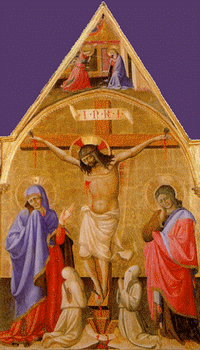 del suo sangue quale cibo di vita eterna. Il
gesto di Gesù mostra la prova suprema del suo amore per la Chiesa e per tutti
gli uomini. Il giovedì santo diventa un rinnovato invito a rendere grazie a Dio
per il sommo dono della eucaristia che va accolto con viva fede e va adorato con
umiltà e totale dedizione.
del suo sangue quale cibo di vita eterna. Il
gesto di Gesù mostra la prova suprema del suo amore per la Chiesa e per tutti
gli uomini. Il giovedì santo diventa un rinnovato invito a rendere grazie a Dio
per il sommo dono della eucaristia che va accolto con viva fede e va adorato con
umiltà e totale dedizione.
2. Il Venerdì Santo, giorno della passione e della crocifissione del Signore,
ricorda quell’evento doloroso e drammatico, ma portatore della nostra salvezza.
Ogni anno, ponendoci in silenzio e in adorazione di fronte a Gesù appeso al
legno della croce, riconosciamo tutta la grandezza, la profondità, la pienezza
del suo amore per noi. Davanti a tale oblazione cruenta della propria vita fino
alla morte umiliante della croce, non possiamo non prostrarci con un senso di
immensa gratitudine e insieme con la consapevolezza dei nostri peccati, dai
quali solo il suo sacrificio ci ha liberati. Se da una parte il venerdì santo è
un giorno pieno di profonda tristezza, al tempo stesso è un giorno ricco di
amore e fonte per ridestare la nostra fede, per affidarci totalmente al Cristo
crocifisso e attingere da lui la forza e la grazia di portare la nostra croce
con il pieno abbandono a Dio, nella certezza che il Crocifisso ci sostiene e ci
dona la vittoria. Per questa ragione la liturgia esplode nel grido di
venerazione e di speranza: “O Croce, salve, tu speranza unica, tu unica
salvezza!”.
 3. Nel Sabato Santo le chiese sono spoglie e silenziose. I fedeli vegliano in
preghiera come Maria e insieme a Maria condividendo gli stessi sentimenti di
dolore e di fiducia in Dio. Il raccoglimento e il silenzio di questo giorno
preparano il nostro animo ad attendere nella notte con la veglia pasquale la
risurrezione di Cristo, quando proromperà in tutta la comunità cristiana il
canto della gioia per la risurrezione di Cristo. Ancora una volta, verrà
proclamata la vittoria della luce sulle tenebre, della vita sulla morte,
dell’amore sull’odio. Ci accompagni in questo giorno la Vergine Santa che ha
seguito in silenzio il figlio Gesù fino al calvario, prendendo parte con grande
pena al suo sacrificio, cooperando così al mistero della redenzione e divenendo
madre di tutti i credenti. Insieme con lei vegliamo accanto al Cristo morto,
attendendo con speranza il giorno radioso della risurrezione.
3. Nel Sabato Santo le chiese sono spoglie e silenziose. I fedeli vegliano in
preghiera come Maria e insieme a Maria condividendo gli stessi sentimenti di
dolore e di fiducia in Dio. Il raccoglimento e il silenzio di questo giorno
preparano il nostro animo ad attendere nella notte con la veglia pasquale la
risurrezione di Cristo, quando proromperà in tutta la comunità cristiana il
canto della gioia per la risurrezione di Cristo. Ancora una volta, verrà
proclamata la vittoria della luce sulle tenebre, della vita sulla morte,
dell’amore sull’odio. Ci accompagni in questo giorno la Vergine Santa che ha
seguito in silenzio il figlio Gesù fino al calvario, prendendo parte con grande
pena al suo sacrificio, cooperando così al mistero della redenzione e divenendo
madre di tutti i credenti. Insieme con lei vegliamo accanto al Cristo morto,
attendendo con speranza il giorno radioso della risurrezione.
Don Renzo Lavatori.
(08-04-2012)
Gesu' risorto datore dello Spirito
 La
sera di quello steso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,
si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro le
mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro
di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”. Dopo
aver detto questo, alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non
rimessi” (GV. 20,19-23).
La
sera di quello steso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,
si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro le
mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro
di nuovo: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi”. Dopo
aver detto questo, alitò su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi
rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non
rimessi” (GV. 20,19-23).
Una volta inserito nella pienezza della vita divina, con la propria umanità
glorificata, attraverso la risurrezione, Gesù non è solo il soggetto che
accoglie lo Spirito, ma diventa essenzialmente il donatore. Infatti, dopo aver
ricevuto dal Padre il dono dello Spirito, egli lo trasmette per sua interna
disposizione al di fuori di sé, si fa sorgente zampillante del dono eterno verso
coloro che condividono la stessa situazione umana e anelano alla vita nuova dei
figli di Dio. Da una parte la sua intima comunione con la gloria del Padre lo
rende partecipe della potenza originaria divina, del suo Spirito d’amore,
dall’altra, per la solidarietà che lo lega al la creatura umana di cui egli
costituisce il primogenito, è il canale attraverso il quale lo Spirito passa
dalla fonte divina all’umanità intera. Gesù risorto così si fa origine e
strumento dello Spirito che si effonde su gli uomini (cf. 1Cor 15,45).
a. Nel giorno di Pasqua
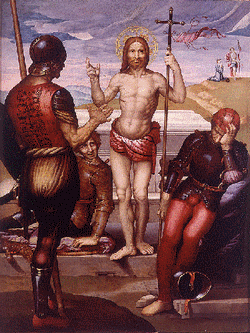 Ecco perché
«la sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse
le porte dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù e
stette in mezzo a loro» (Gv 20,19). L’evangelista ci tiene a sottolineare il
tempo in cui Gesù appare ai discepoli: è la sera del giorno della risurrezione,
il nuovo giorno che inaugura i tempi ultimi. Di tale giorno egli aveva accennato
ai suoi nella promessa del Paraclito, lo Spirito di verità, in virtù del quale
essi avrebbero conosciuto la comunione di Gesù con il Padre e dei discepoli con
Gesù (Gv 14,20). Quel giorno si è attuato con il giorno della risurrezione, il
primo dopo il sabato. È il giorno quindi della realizzazione della promessa, il
giorno in cui viene comunicato il dono dello Spirito. Gesù è in mezzo a loro,
come nell’ultima cena, ma questa volta non più nella debolezza della carne ma
nella gloria sfolgorante della risurrezione, con la quale il suo corpo di carne,
di cui le piaghe mostrano bene la realtà della morte, è stato trasfigurato in un
corpo ricolmo di Spirito. Egli ormai è l’uomo nuovo, l’uomo datore dei doni
messianici: la pace, la gioia, la remissione dei peccati, la missione, ma il più
grande e il più significativo è il do no dello Spirito, che li contiene tutti e
li riassume (Gv 20,20-23). Ed è proprio il dono dello Spirito che acquista un
valore particolare nell’insieme del racconto. Prima Gesù dona la pace, poi
mostra le mani e il costato, a cui segue la gioia dei discepoli nel vedere il
Signore. Riprende la comunicazione della pace, che costituisce il motivo
ripetitivo, quale espressione della realtà messianica di Gesù. Egli l’aveva
promessa nella sua vita terrena (Gv 14,27; 16,33), ma ora la trasmette loro
realmente. È la «sua pace», non come quella del mondo, la pace cioè che i
discepoli possono avere solo da lui e in lui. Poi Gesù conferisce loro la
missione, ch’egli a sua volta ha ricevuto dal Padre: «Come il Padre ha mandato
me anch’io mando voi» (Gv 20,21b). Così aveva già pregato nel cenacolo: «Come tu
mi hai mandato nel mondo, anch’io li ho mandati nel mondo» (Gv 17,18). Con la
missione i discepoli so no intimamente uniti a Gesù, con quello stesso pro fondo
legame che unisce Cristo al Padre. Essi in tal modo entrano in comunione con il
Padre e, attraverso Cristo, si rapportano a lui quale principio e sorgente
ultima della
Ecco perché
«la sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse
le porte dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù e
stette in mezzo a loro» (Gv 20,19). L’evangelista ci tiene a sottolineare il
tempo in cui Gesù appare ai discepoli: è la sera del giorno della risurrezione,
il nuovo giorno che inaugura i tempi ultimi. Di tale giorno egli aveva accennato
ai suoi nella promessa del Paraclito, lo Spirito di verità, in virtù del quale
essi avrebbero conosciuto la comunione di Gesù con il Padre e dei discepoli con
Gesù (Gv 14,20). Quel giorno si è attuato con il giorno della risurrezione, il
primo dopo il sabato. È il giorno quindi della realizzazione della promessa, il
giorno in cui viene comunicato il dono dello Spirito. Gesù è in mezzo a loro,
come nell’ultima cena, ma questa volta non più nella debolezza della carne ma
nella gloria sfolgorante della risurrezione, con la quale il suo corpo di carne,
di cui le piaghe mostrano bene la realtà della morte, è stato trasfigurato in un
corpo ricolmo di Spirito. Egli ormai è l’uomo nuovo, l’uomo datore dei doni
messianici: la pace, la gioia, la remissione dei peccati, la missione, ma il più
grande e il più significativo è il do no dello Spirito, che li contiene tutti e
li riassume (Gv 20,20-23). Ed è proprio il dono dello Spirito che acquista un
valore particolare nell’insieme del racconto. Prima Gesù dona la pace, poi
mostra le mani e il costato, a cui segue la gioia dei discepoli nel vedere il
Signore. Riprende la comunicazione della pace, che costituisce il motivo
ripetitivo, quale espressione della realtà messianica di Gesù. Egli l’aveva
promessa nella sua vita terrena (Gv 14,27; 16,33), ma ora la trasmette loro
realmente. È la «sua pace», non come quella del mondo, la pace cioè che i
discepoli possono avere solo da lui e in lui. Poi Gesù conferisce loro la
missione, ch’egli a sua volta ha ricevuto dal Padre: «Come il Padre ha mandato
me anch’io mando voi» (Gv 20,21b). Così aveva già pregato nel cenacolo: «Come tu
mi hai mandato nel mondo, anch’io li ho mandati nel mondo» (Gv 17,18). Con la
missione i discepoli so no intimamente uniti a Gesù, con quello stesso pro fondo
legame che unisce Cristo al Padre. Essi in tal modo entrano in comunione con il
Padre e, attraverso Cristo, si rapportano a lui quale principio e sorgente
ultima della
missione. La missione consiste principalmente nel comuni care la comunione di
amore trinitario, nella quale gli uomini trovano la vera riconciliazione con Dio
e tra di loro. La remissione dei peccati è precisamente la grazia di poter
attuare l’unione con Dio, al di sopra di ogni egoismo umano, quell’unione che
raggiunge la profondità del rapporto del Figlio verso il Padre nella potenza
vivificante dello Spirito.
b. L’effusione dello Spirito
A tale scopo è dato lo Spirito Santo. Infatti lo Spirito, per sua natura
personale, è il principio di ogni comunione, non solo all’interno della vita
trinitaria, ma anche nell’incontro che si stabilisce tra Dio e l’umanità in
virtù dell’opera del Figlio incarnato. Proprio per il dono di questo Spirito, la
pace e la remissione dei peccati, che Gesù comunica ai discepoli quale loro
missione, può trovare il giusto e pieno compimento. Perciò la remissione dei
peccati è opera dello Spirito Santo. «Dopo aver detto questo, alitò su di loro e
disse: Ricevete lo Spirito Santo» (Gv 20,22). Gesù compie un gesto, quello di
alitare, a cui accompagna le parole con le quali comunica lo Spirito. Il gesto
indica l’infusione della vita. Ma è Dio che in fonde la vita. Gesù risorto è
colui che dona la vita come fa Dio, poiché possiede la stessa potenza vivi
peccatrice. Tuttavia questa vita non è tanto a livello naturale della creazione
o della vita terrena dell’uomo, ma è la vita dello Spirito, quella vita che è
propria di Dio, del suo essere intimo. Essa è data dal soffio eterno che scorre
continuamente dal Padre al Figlio e che li rende un solo Spirito vivificante.
Questa è la vita vera, che i discepoli sono stati chiamati a diffondere nel
mondo, dopo che essi da Cristo risorto hanno ricevuto in pienezza il soffio
eterno della vita, il dono dello Spirito.
Don Renzo Lavatori
DOMENICA IN ALBIS OTTAVA DI PASQUA
(15-04-2012)
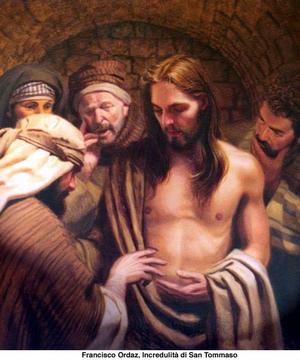 La sera di quel
giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse
loro: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore, Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi!
Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”. Detto questo, soffiò e disse
loro: “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati”. Tommaso, uno
dei Dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano
gli altri discepoli: “Abbiamo visto il Signore!”. Ma egli disse loro: “Se non
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo”. Otto giorni dopo i
discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a
porte chiuse, stette in mezzo e disse: “Pace a voi!”. Poi disse a Tommaso:
“Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio
fianco; e non essere incredulo ma credente!”. Gli rispose Tommaso: “Mio Signore
e mio Dio!”. Gesù le disse: “Perché mi hai veduto, tu mi hai creduto; Beati
quelli che non hanno visto e hanno creduto!”. Gesù, in presenza dei suoi
discepoli, fecce molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro.
Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. (Gv. 20,19-31).
La sera di quel
giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse
loro: “Pace a voi!”. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore, Gesù disse loro di nuovo: “Pace a voi!
Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”. Detto questo, soffiò e disse
loro: “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati”. Tommaso, uno
dei Dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano
gli altri discepoli: “Abbiamo visto il Signore!”. Ma egli disse loro: “Se non
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei
chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo”. Otto giorni dopo i
discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a
porte chiuse, stette in mezzo e disse: “Pace a voi!”. Poi disse a Tommaso:
“Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio
fianco; e non essere incredulo ma credente!”. Gli rispose Tommaso: “Mio Signore
e mio Dio!”. Gesù le disse: “Perché mi hai veduto, tu mi hai creduto; Beati
quelli che non hanno visto e hanno creduto!”. Gesù, in presenza dei suoi
discepoli, fecce molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro.
Ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. (Gv. 20,19-31).
Il brano del vangelo di Giovanni mostra il cammino di fede verso il Cristo
risorto da parte dell’apostolo Tommaso, quale esempio per ogni discepolo che
voglia credere in modo pieno e radicale. Esso fa riflettere profondamente e ci
invita a fare attenzione ad ogni gesto di questo racconto luminoso e vivace.
Siamo nel giorno ottavo dopo la risurrezione di Cristo. I discepoli sono
raccolti in casa e di nuovo Gesù appare loro e in particolare si rivolge proprio
a Tommaso.
1. La incredulità di Tommaso
La incredulità di Tommaso verso il Risorto non è provocata da animo cattivo, ma
dalla ristrettezza della mente, legata alla visione terrena delle cose. Sotto
questo aspetto egli può essere identificato con ogni discepolo di Cristo, prima
dell’esperienza pasquale (cf. Mt 28,7; Mc 11-13.14; Lc 24,11.25.38.41). Per tale
ragione non accetta la dichiarazione dei suoi amici: “Abbiamo visto il Risorto”
(Gv 20,25). Per lui è un’affermazione soltanto teorica. Anche lui ha visto il
Signore, ma sulla croce; è rimasto toccato da quei chiodi, da quelle ferite, da
quel dolore atroce. Com’è possibile una visione diversa del Cristo? Egli è fermo
al crocifisso e non vuole spostarsi di là. A quello, sì, ci crede, perché lo ha
visto realmente. Il resto sono tutte fantasie. Si spiega così la sua richiesta
di una prova concreta e tangibile: vedere il segno dei chiodi e toccare le
ferite di Gesù. Solo allora anch’egli potrà credere.
Si nota in Tommaso una certa durezza e un indugio alla fede, non un rifiuto. È
vero che una fede basata sul vedere fisico non è sufficiente, ma può essere un
inizio che conduce alla piena fede cristologica, diversamente da coloro che pur
avendo visto non hanno creduto (Gv 6,36). Tuttavia una fede fondata sulla sola
parola di Gesù è superiore (cf. Gv 10,38; 14,11). L’evangelista vuole descrivere
un cammino completo di fede. Per questo introduce l’apparizione del Risorto, a
porte chiuse (Gv 20,26), nella realtà di corpo glorioso, quasi per scuotere
l’animo dubbioso e incerto di Tommaso.
2. La disponibilità di Gesù
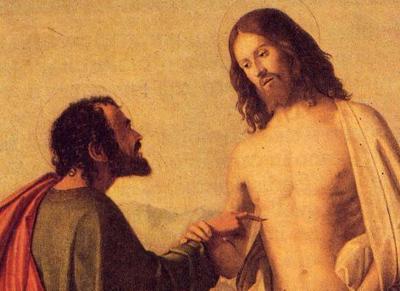 Gesù rinnova il saluto
pasquale: “Pace a voi”, poi si rivolge subito a Tommaso. È chiara l’intenzione
di muovere il cuore del discepolo. Egli riprende testualmente le espressioni
proferite dall’apostolo ai suoi amici: “Metti qua il tuo dito e guarda le mie
mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato” (Gv 20,27). La ripetizione
delle parole, che Tommaso aveva detto agli altri, serve a colpirlo nell’intimo.
Egli si rende conto che Gesù vede nell’animo e prova vergogna di se stesso,
insieme rimane sorpreso della bontà del Maestro, che gli viene incontro per
esaudire il suo desiderio. Sono due segni precisi, la conoscenza divina e la
misericordia, che fanno cadere ogni resistenza.
Gesù rinnova il saluto
pasquale: “Pace a voi”, poi si rivolge subito a Tommaso. È chiara l’intenzione
di muovere il cuore del discepolo. Egli riprende testualmente le espressioni
proferite dall’apostolo ai suoi amici: “Metti qua il tuo dito e guarda le mie
mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato” (Gv 20,27). La ripetizione
delle parole, che Tommaso aveva detto agli altri, serve a colpirlo nell’intimo.
Egli si rende conto che Gesù vede nell’animo e prova vergogna di se stesso,
insieme rimane sorpreso della bontà del Maestro, che gli viene incontro per
esaudire il suo desiderio. Sono due segni precisi, la conoscenza divina e la
misericordia, che fanno cadere ogni resistenza.
Poi il Signore lo richiama alla fede: “Non essere incredulo, ma credente” (Gv
20,27). Infatti c’era il pericolo che Tommaso diventasse miscredente, dopo il
fallimento della croce, se l’aiuto di Gesù non l’avesse sorretto e stimolato.
Egli deve approfondire l’esperienza precedente, non può fermarsi ad una
concezione generica del Messia, ma deve accogliere il Figlio dell’uomo
glorificato dopo la sua morte. La sua fede deve diventare un’adesione a Cristo
nel senso pieno e maturo.
All’invito di Gesù Tommaso apre il suo cuore e proclama con sincerità e totalità
la sua convinzione: “Mio Signore e mio Dio!” (Gv 20,28). È una professione
calorosa, un’espressione di adorazione, una preghiera, un ringraziamento. Certo
è molto più di un semplice riconoscimento del Messia. Essa indica la certezza
proveniente dall’animo dell’apostolo, ma risuona in tutta la Chiesa ed è valida
per ogni credente di ogni tempo. È una formula che esprime l’essenza stessa del
vangelo di Giovanni. Tommaso ha riconosciuto nel Risorto, che identifica con il
crocifisso e con il Gesù terreno a lui familiare, ora glorioso, una persona che
è pienamente Dio, il suo Signore.
Gesù accoglie la confessione sincera di Tommaso, ma gli rimprovera di aver
creduto solo dopo aver visto (Gv 20,29). Il percorso di fede ha portato
l’apostolo a riconoscere il Risorto attraverso la constatazione sensibile della
sua presenza, come d’altronde hanno fatto gli altri discepoli. Ciò non sarà più
possibile ai credenti che verranno dopo di loro, i quali dovranno credere in
Cristo senza poter toccare o vedere il suo corpo glorioso, ma fidandosi della
testimonianza degli apostoli. Essi saranno ugualmente beati, perché, per mezzo
della fede, potranno avere lo stesso rapporto di comunione e di amore con Gesù,
il quale è ormai vivo e presente nella Chiesa.
Don Renzo Lavatori
 |  | 16 / 49 |
 |  |